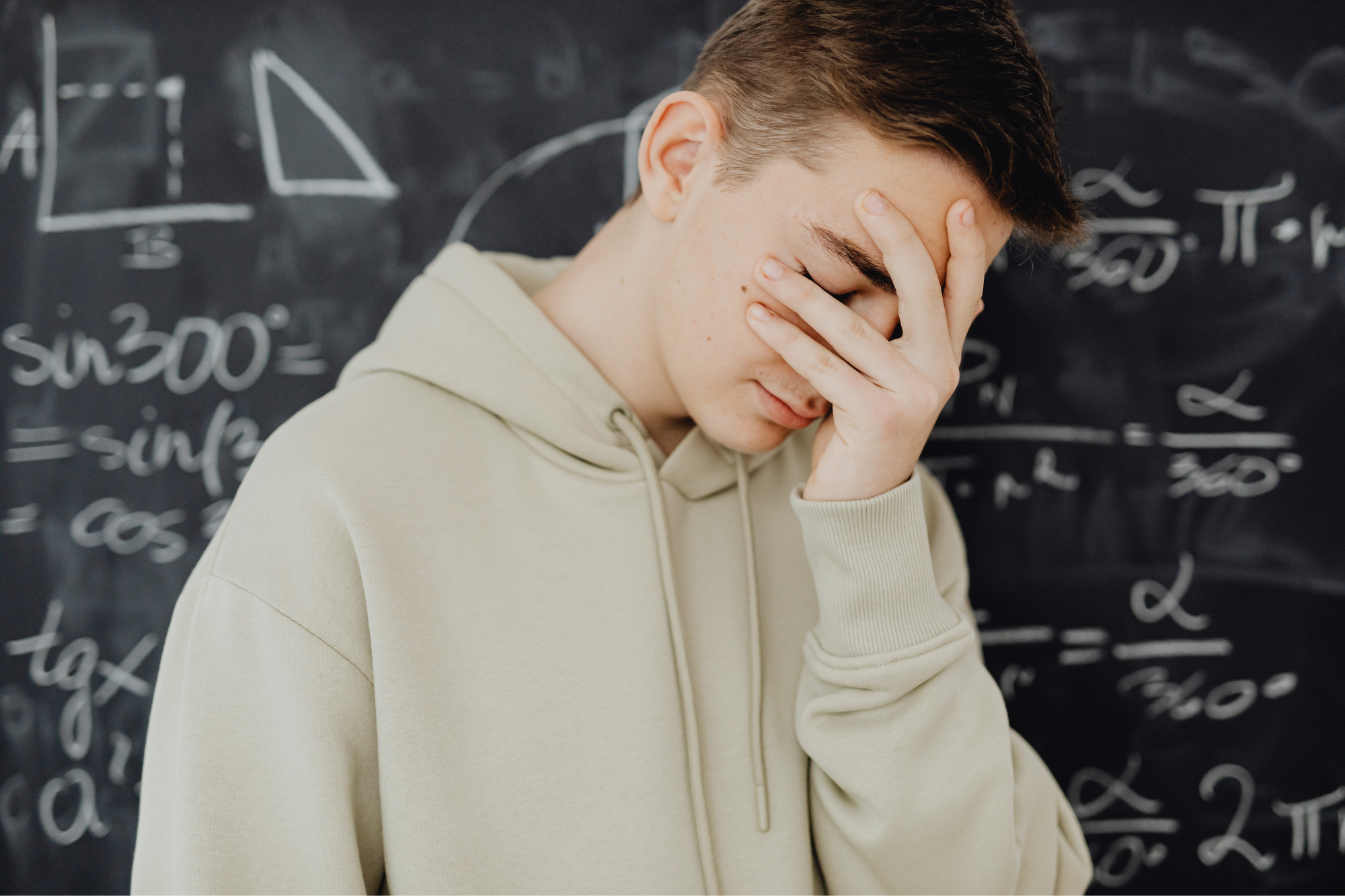Maturità 2025, tra errori e confusioni: il “bestiario” degli orali
- 3 Luglio 2025
- Giovani
Anche quest’anno, con gli orali della Maturità ancora in corso in tutta Italia, torna puntuale il consueto “bestiario” degli errori più eclatanti. Come da tradizione, il portale Skuola.net, grazie alle segnalazioni arrivate direttamente dagli studenti, ha raccolto gli strafalcioni più eclatanti ascoltati durante i colloqui. E se ogni edizione dell’Esame di Stato offre il suo campionario di scivoloni, il 2025 non fa eccezione. Anzi, rilancia: Hitler vincitore del Nobel per la Pace, Marie Curie premiata con due Oscar, D’Annunzio trasformato in un estetista. Errori che fanno sorridere, ma che – a ben guardare – raccontano qualcosa di più profondo.
Non si tratta solo di lapsus o scarsa preparazione individuale. Il punto è che gli stessi equivoci, le stesse confusioni, le stesse interpretazioni errate tornano puntuali, anno dopo anno, quasi fossero sintomo di una difficoltà collettiva, strutturale. Una difficoltà che non nasce con l’esame di Stato, ma che parte molto prima. Lo confermano dati già noti: per molti italiani l’autore de “L’Infinito” è D’Annunzio (e non Leopardi, ndr), per qualcuno Verdi ha scritto l’Inno di Mameli e quasi il 13% della popolazione adulta è in dubbio sul fatto che 7×8 faccia davvero 56. In questo quadro, gli strafalcioni degli esami non sorprendono più. Ma dovrebbero comunque far riflettere.
La letteratura rimescolata
Anche quest’anno la letteratura è il terreno preferito per le scivolate. Alcune risposte non sembrano semplici errori, ma vere reinvenzioni. Spicca su tutti l’“estetista” Gabriele D’Annunzio. Un’associazione probabilmente nata per assonanza, ma che nulla ha a che vedere con il ruolo di intellettuale e scrittore ricoperto dal poeta. Non è finita qui. “La pioggia nel pineto”, una delle poesie più note di D’Annunzio, è stata attribuita a Giovanni Pascoli. Lo stesso Pascoli, in un altro colloquio, è stato descritto come autore della “frantumazione dell’io”, concetto centrale dell’opera di Pirandello. Un gioco di scambi in cui i maturandi si muovono a tentoni, confondendo stili, epoche e nomi come in un quiz improvvisato.
Il confine tra autore e ambientazione storica salta del tutto con Alessandro Manzoni, spostato dall’Ottocento al Seicento – secolo in cui “I Promessi Sposi” sono ambientati. E poi c’è il caso di Émile Zola, promosso a scrittore italiano: forse confuso con l’ex calciatore Gianfranco Zola, forse no, ma certo non francese.
La storia reinventata
La Storia non se la passa meglio. Il caso più eclatante? Il Premio Nobel per la Pace ad Adolf Hitler. Una frase che lascia poco spazio alle interpretazioni. E l’elenco continua: un altro maturando ha sostenuto che Auschwitz fu liberato dagli americani. In realtà, il campo di sterminio fu raggiunto e aperto dall’Armata Rossa sovietica il 27 gennaio 1945 (una data che in Italia viene ricordata ogni anno con la Giornata della Memoria, ma che, evidentemente, continua a non essere assimilata da tutti).
Ancora più sorprendente, la ricostruzione temporale della Seconda Guerra Mondiale: per uno studente, l’inizio del conflitto risale al 1933, anno della nomina di Hitler a cancelliere della Germania. Ma il 1939 – con l’invasione della Polonia – segna lo scoppio effettivo della guerra. Una differenza di sei anni non trascurabile.
In mezzo a queste distorsioni, c’è anche chi ha ribaltato le basi dell’ordinamento istituzionale italiano. Secondo una risposta emersa durante un orale, l’Italia sarebbe ancora oggi una monarchia. Ignorato del tutto – o rimosso – il referendum del 2 giugno 1946 che sancì la nascita della Repubblica, con un’affluenza altissima e un voto storico.
La confusione tocca anche la storia più recente. Uno studente ha attribuito il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro a Cosa Nostra. La verità storica, come sappiamo, è un’altra: il presidente della Democrazia Cristiana fu rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978, in un’operazione che segnò l’apice della strategia del terrorismo politico in Italia.
Le altre materie non se la passano meglio
Gli errori più vistosi non riguardano solo Storia e Letteratura. Anche Scienze e Arte collezionano svarioni notevoli. Marie Curie, ad esempio, è stata indicata come vincitrice di due premi Oscar. Lo studente probabilmente voleva dire “Nobel” – che Curie ha effettivamente ricevuto, uno per la Fisica e uno per la Chimica – ma ha confuso i riconoscimenti accademici con quelli cinematografici.
Nel campo dell’arte, invece, la vittima abituale degli orali è Pablo Picasso. Uno studente lo ha ribattezzato “Paolo”, e fin qui potrebbe trattarsi di una svista. Meno giustificabile è la descrizione della “Guernica” come un quadro ‘rosso’, quando invece è una delle opere in bianco e nero più famose della storia dell’arte contemporanea.
Non si salva nemmeno la commissione d’esame: durante una domanda sul Dna, un professore ha coinvolto la madre e la sorella gemella di una candidata presenti fuori dall’aula, per chiedere se condividessero lo stesso patrimonio genetico. Una scena insolita, che ha trasformato l’orale in una piccola tavola rotonda familiare.
Altra nota significativa: una professoressa di arte ha indicato il 1919 come anno di nascita del Futurismo, mentre il manifesto fondativo firmato da Marinetti è del 1909. A correggerla, il collega di storia, innescando un dibattito tra commissari davanti agli studenti. Altro episodio segnalato riguarda un commissario d’inglese che, parlando di Charles Dickens, ha continuato a riferirsi a “The Picture of Dorian Gray”, che però è di Oscar Wilde. L’errore è stato ripetuto più volte senza correzione.
Nel frattempo, c’è anche chi ha interrogato su una materia non prevista. È successo con il Latino: un docente ha rivolto più domande sull’argomento, nonostante la disciplina non fosse presente nel programma della classe.
Oltre ai contenuti, a preoccupare in alcuni casi è l’atteggiamento. Un candidato ha scelto di rimanere in silenzio per tutto l’orale. Nessuna risposta, nessun commento, nessun segnale. Forse puntava a una promozione già acquisita, forse ha deciso che l’esame non meritava uno sforzo. Ma la scena è stata segnalata come emblematica. In un altro caso, uno studente ha risposto “non lo so” a tutte le domande di scienze. Alla fine, la prof gli ha chiesto: “Almeno una cosa ti è piaciuta quest’anno?”. La risposta: “No”. La docente ha concluso: “Ci saranno provvedimenti”. Reazione inevitabile, anche se difficile da valutare in termini di esito.